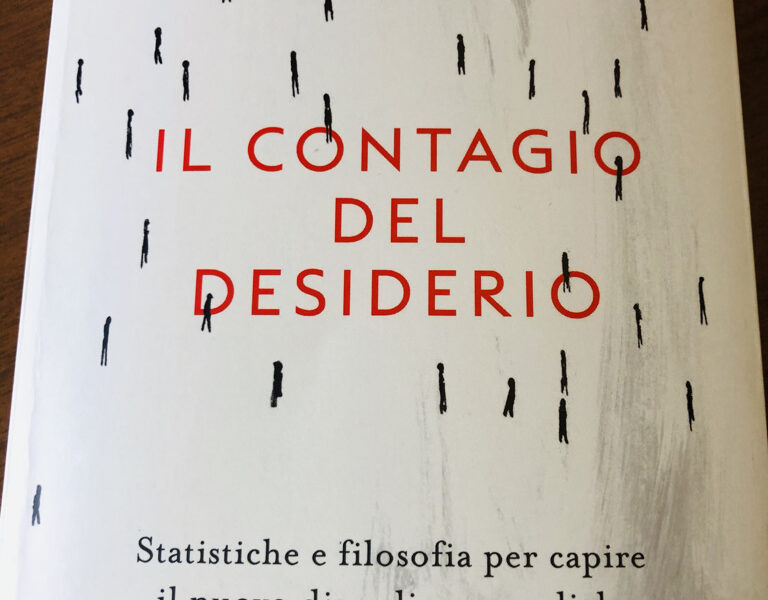Per capire cosa sta succedendo nel mondo
Cosa è andato storto dopo questi trent’anni di globalizzazione
questo testo sembra capace di rispondere a queste domande in maniera intelligente.. con dati alla mano. L’autore e il direttore del Censis
Siamo arrivati alla fine?
Siamo arrivati davvero alla fine della «fine della storia» profetizzata da Kojève? E dobbiamo credere che la storia si stia rimettendo in moto? Ma se la storia ricomincia — la storia è «un banco di macellaio», diceva Hegel — si ripresenterà con tutto il suo significato tragico? Con il ritorno degli Stati rivali come un tempo e delle guerre fra gli Stati? Pensateci: i sommari di storia su cui tutti abbiamo studiato sui banchi di scuola non sono altro che una ininterrotta sequela di feroci battaglie, di conflitti crudeli, di sollevazioni e spietate repressioni, di massacri e asservimenti, di tirannie e servitù, di contese per la conquista del potere e poi di spartizioni dei bottini in quei consessi internazionali chiamati conferenze di pace. Sono le calamità a fare la storia. Inoltre, possiamo facilmente rinunciare ai risultati economici, sociali e politici raggiunti negli ultimi trent’anni, dopo il tramonto delle grandi, terribili ideologie del ‘900? Sono domande dai risvolti inquietanti. Ma è da questi interrogativi che oggi bisogna ripartire per provare a in-dovinare quale sarà il nostro futuro.
pag 23
Come mai questa inquietitudine?
In questo ciclo storico trentennale di «fine della storia», però, è successo anche qualcos’altro, che spiega in buona misura la nostra grande inquietudine di oggi, la sensazione di essere giunti al crepuscolo del mondo per come lo avevamo conosciuto finora. Come conseguenza dell’apertura delle frontiere, della liberalizzazione dei commerci e dell’incremento del volume degli scambi internazionali, nel lungo periodo è avvenuto un riequilibrio dei pesi economici dei diversi paesi del mondo: un accorciamento delle distanze, un tempo abissali, esistenti tra i paesi ricchi e pienamente sviluppati, da una parte, e quelli ín ritardo di sviluppo, dall’altra. Non solo un riequilibrio, per la verità, perché in molti casi si è trattato di un vero e proprio sorpasso. Consideriamo i due player globali oggi più importanti: USA e Cina. Nel 2019 il PIL degli Stati Uniti ammontava a 21.428 miliardi di dollari in valori correnti, quello cinese misurava 14.343 miliardi. poi tutto è cambiato…
E l’Europa? Trentanni fa ai paesi dell’Unione europea era attribuibile il 24% della produzione mondiale , oggi solo poco più del 13 per cento. Il peso dell’economia italiana, in particolare, si è ridimensionato dal 4,2 all’1,7 per cento del PIL del mondo. La Germania, per esempio, è stata sorpassata dall’India: nel 1989 produceva 1.495 miliardi di dollari PPP, l’India 905 miliardi, ma trent’anni dopo la produzio-ne indiana ha raggiunto un valore di 11.043 miliardi di dollari PPP e quella tedesca vale 4.444 miliardi, cioè due volte e mezza di meno . Nel 1989 il PIL dell’Italia era di 1.077 miliardi di dollari PPP, quello dell’Indonesia era pari a circa la metà (459 miliardi), ma già nel 2011 i due valori erano coincidenti, poi l’anno successivo è avvenuto il sorpasso: nel 2019 ai 2.455 miliardi di dollari PPP dell’Italia si contrappongono i 3.736 miliardi dell’Indonesia. A inizio periodo il PIL del Messico raggiungeva 673 miliardi di dollari PPP, aumentati fino a 2.616 miliardi a fine periodo: anche il Messico nel 2014 ha sorpassato l’Italia. Secondo questo metodo di misurazione, a guidare la classifica delle principali economie del mondo oggi compaiono paesi tradizionalmente sviluppati fianco a fianco con paesi appartenenti ad aree del pianeta che eravamo abituati a considerare secondarie. Prima è la Cina, seguita dagli Stati Uniti, poi ci sono l’India, il Giappone, la Germania e la Russia, poi al settimo posto nel mondo c’è l’Indonesia, poi ancora il Brasile, solo dopo vengono Regno Unito e Francia, ecco poi il Messico, l’Italia, la Turchia e la Corea del Sud, poi la Spagna e il Canada, a seguire Arabia Saudita, Iran, Egitto e Thailandia, prima dell’Australia, che precede Taiwan, segue la Polonia, quindi compare il primo paese dell’Africa sub-sahariana, un paese produttore di petrolio come la Nigeria, poi il Pakistan. Alla prova delle evidenze empiriche, è strabiliante l’effetto della universale omogeneizzazione kojèviana nei rapporti di forza tra i diversi paesi e le diverse regioni del pianeta.
La lezione che abbiamo appreso dall’ultimo scorcio di storia è che le moderne democrazie liberali stanno perdendo la capacità di rispondere ai bisogni sociali come riuscivano a fare in passato. Per questo motivo nel discor-so pubblico hanno cominciato a farsi strada, senza più i pudori e le censure dí una volta, gli argomenti a favore delle «democrazie illiberali». Non che i meccanismi della globalizzazione degli ultimi trent’anni non abbiano bisogno dí correttivi (dal depauperamento delle risorse naturali alla iniqua distribuzione del dividendo sociale della crescita). Ma alla fine si rischia di buttare via il bambino con l’acqua sporca: non soltanto i risultati economici raggiunti, ma anche i diritti individuali conquistati.
Da cosa nasce la nostra grande inquietudine, allora? Il fatto è che con la globalizzazione non sono arrivati solo prodotti a buon mercato dall’Asia e non si sono solo aperti nuovi mercati di sbocco per gli imprenditori esporta-tori. Come effetto, diretto o indiretto, della progressiva integrazione delle economie del mondo, molte fabbriche di lunga tradizione in Europa e in America hanno chiuso e sono saltate in aria intere filiere produttive — non esclusivamente la grande industria siderurgica e quella estrattiva, ma anche numerose imprese manifatturiere tessili e meccaniche, mentre milioni di posti di lavoro trovavano una diversa e più conveniente dislocazione geografica. Per queste ragioni molte comunità locali sono state sconvolte: si sono ritrovate private dei loro tradizionali punti fermi e sono state disorientate dalla crescente apertura dei confini nazionali a popolazioni portatrici di culture, religioni e stili di vita profondamente diversi dai propri. La desertificazione delle company town americane e il collasso di intere economie locali in Italia e in Europa, come conseguenza del declino di determinate attività manifatturiere, hanno alimentato la sensazione di molti di essere rimasti orfani di un orgoglio identitario e di essere stati spogliati delle loro tradizionali fonti di rispecchiamento a causa della maggiore omogeneizzazione etnica e culturale. Lo sconcerto provocato da un simile cambiamento radicale è risultato intollerabile anche per chi non avrebbe fondate preoccupazioni economiche, né pericoli ogget-tivi da temere: anche per chi, pur conducendo una vita agiata, rimpiange le antiche certezze del passato e ora vuole mettere fine al cambiamento trincerandosi dietro nuove barriere nazionali. Perché in molti sentono di aver perso quello per cui loro e le generazioni antecedenti alla loro avevano lottato, per giungere, dopo un lungo e impervio cammino, alla fine della storia: il riconoscimento sociale, per dirla con Hegel-Kojève. Insieme all’antica sovranità dello Stato-nazione si è indebolita l’identità stessa delle persone. E ora tutto il nuovo che è arrivato, e che in breve ha un nome preciso — globalizzazione —, viene percepito come un agente di corruzione delle fonti tradizio-nali di rassicurazione e, in definitiva, come un attentato al proprio orgoglio identitario. L’impatto sociale della globalizzazione è stato decisamente sottovalutato. E ora le reazioni irrompono con tutta la loro violenza e contagiano la sfera politica, in cui si riaffacciano le pulsioni nazionaliste a cui molte società occidentali, a cominciare da quelle europee, avevano rinunciato da decenni. Perché in gioco c’è una minaccia all’identità più profonda, avvertita da un numero crescente di persone.
L’identità americana, basata su una secolare supremazia economica, tecnologica e militare, ora vede il proprio primato messo a repentaglio e torna a rivendicarlo a gran voce: «America first!», «Make America great again!». Gli gridano: italiani smarriti nella loro identità perduta ora. «Prima gli italiani!». Analogamente, come è noto, in ogni socíetà europea si sono fatti largo movimenti liti i e culturali di impronta nazionalista fortemente orietati alla protezione identitaria.
Messe a dura legate all’oggettivo ridimensionamento del ruolo economico giocato alla scala planetaria, in cui adesso si affacciano nuovi protagonisti, le leadership politiche nazionali progettano di scaldare i cuori dei loro elettori con la proposta di misure più restrittive all’ingresso degli stranieri sul proprio territorio e dei prodotti fabbricati all’estero nei propri mercati di consumo. La globalizzazione, da promessa di nuove opportunità di benessere per tutti, ora evoca uno spettro: il fantasma di un declassamento economico e sociale. Come avvalorato dai dati mostrati nel capitolo precedente, alla corsa della Cina e degli altri paesi emergenti non ha corrisposto soltanto un riallineamento dei tradizionali squilibri sociali del pianeta. In prospettiva, per noi quei numeri significano il pericolo concreto di una retrocessione economica e geopolitica, con una Europa fragile come un vaso di coccio tra Oriente e Occidente. Così nelle nostre coscienze si è insinuata la segreta paura che prima o poi qualcuno ci toglierà dal piedistallo del benessere e prenderà il nostro posto.
È questo il punto critico del canone occidentale del desiderio — il cono d’ombra in cui íl desiderio di riconoscimento si è infilato. E questa la ragione profonda della nostra profonda inquietudine, per la quale non abbiamo ancora trovato un valido antidoto. pagg 29, 38-41